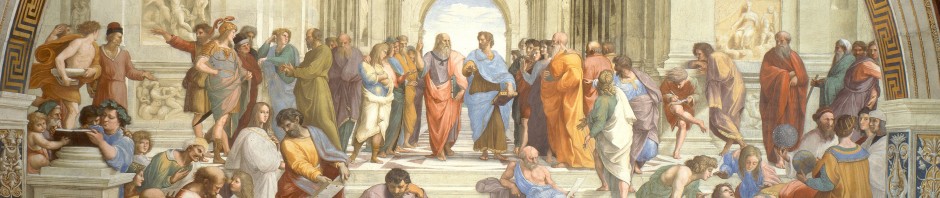La vita
Re e tiranno
La morale
Il tempo
La vita
Nella Roma imperiale la filosofia che ebbe maggior successo fu quella stoica: allo stoicismo ci si poteva appellare per difendere tanto l’interesse verso la politica, quanto il disinteresse, tanto l’abbandono al destino, quanto lo sforzo del singolo.
Seneca fu un caso emblematico di questa lettura dello stoicismo. Egli nacque a Cordova, in Spagna, nel 4 d.C., in seguito si trasferì a Roma dove abbracciò lo stoicismo e si dedicò alla vita politica. Venne esiliato nel 41 dall’imperatore Claudio che lo aveva accusato di adulterio, fu mandato in Corsica dove rimase otto anni. In questi otto anni, come era già stato per Cicerone, fu praticamente costretto a dedicarsi alla filosofia, sono infatti gli anni in cui è possibile riscontrare la sua maggior produzione. Nel 49 tornò a Roma dove divenne precettore di Nerone. Quando questo salì al potere, Seneca gli restò accanto fino al 62, anno in cui Nerone fece uccidere il prefetto del pretorio Afranio Burro e Seneca preferì allontanarsi dal potere. Nel 65 venne accusato di aver preso parte alla congiura dei Pisoni e fu costretto a suicidarsi.
Seneca non era un filosofo di scuola, anzi egli rivendicava la sua libertà di pensiero asserendo che i grandi pensatori del passato non sono i nostri padroni ma soltanto le nostre guide. Seneca nelle prime trenta epistole a Lucilio conclude sempre con una massima tratta dai testi Epicuro, una massima valida, infatti, per Seneca è valida anche se a dirla è stato qualcuno di cui non si condivide il pensiero.
Re e tiranno
Alla salita al potere di Nerone, Seneca scrisse il “De clementia”, nel quale ravvisava la differenza fra re e tiranno nell’uso della clemenza, ossia nella capacità di perdonare: infatti si può chiamare re il tiranno Dionigi e niente impedisce di chiamare tiranno Silla che smise di uccidere solo perché non aveva più nemici da far fuori. Seneca intendeva con questo scritto offrire una sorta di programma politico all’imperatore. Nell’opera sottolinea come il principato fosse legittimo in quanto era la forma di governo che più si avvicinava all’ordine cosmico, retto appunto da un unico logos, ma il problema era quello di avere un buon re. Seneca inoltre afferma che “Senza un avversario la virtù marcisce”, in parole povere la tirannia diventa paradossalmente il mezzo grazie al quale è possibile ritrovare la propria libertà.
La morale
Da buon stoico quale era Seneca non condanna affatto il suicidio, il saggio infatti ha interesse a vivere bene, non a vivere il più a lungo possibile, pertanto il suicidio diventa l’unico mezzo che consente di sottrarsi ad una situazione in cui la virtù non è più perseguibile. Per questo motivo Catone Uticense divenne per gli stoici un simbolo dell’opposizione al principato. Vivere infatti non è un bene di per se, ma è un bene vivere bene, il saggio pertanto si preoccupa di morire bene e si muore bene quando continuare a vivere significherebbe vivere male.
Costretto all’esilio, la filosofia diventa innanzi tutto per Seneca un punto di partenza per opporsi ad un mondo minaccioso al quale non si può scappare, l’errore fondamentale consiste allora nell’attribuire valore alle cose che dipendono dal fato. La massima di Seneca “ducunt volentem fata, nolentem trahunt” (il fato conduce chi si vuol far condurre e trascina gli altri) esprime benissimo questo concetto del destino. Un cane attaccato ad un carro può decidere se correre appresso al carro o se farsi trascinare.
Dal momento che ogni potere sul mondo materiale è perso, si può facilmente capire la posizione di Seneca sulla schiavitù: egli infatti affermava quel principio dell’uguaglianza tra gli uomini più volte accennato da molti filosofi ma mai portato fino in fondo: tutti infatti siamo schiavi, chi di una cosa chi di un’altra siamo tutti schiavi, così la schiavitù giuridica non ha alcuna rilevanza maggiore rispetto alla schiavitù del vizio, anzi è proprio la schiavitù volontaria ad essere la più vergognosa. Inoltre è controproducente trattare male i propri schiavi, poiché uno schiavo trattato male parlerà male del suo padrone in privato, mentre uno schiavo che viene invitato ai banchetti e viene trattato bene sarà disposto a tutto per il suo padrone.
Nel “De providentia” Seneca invece affronta il problema di come sia possibile, in un mondo retto dal logos, che i giusti si trovino spesso a patire molte ingiustizie, mentre gli altri riescono sempre a cavarsela. Seneca risponde dicendo che la divinità si comporta come un maestro con i suoi scolari, richiedendo di più a coloro che promettono di riuscire meglio degli altri, inoltre è anche un modo per consentire al migliore di mettere alla prova le sue qualità, di farle vedere.
Il tempo
Nel “De brevitate vitae” Seneca affronta il problema del tempo, affermando che il tempo di cui disponiamo non è poco, ma siamo noi a renderlo tale sprecandolo, allo stesso modo di come grandi ricchezze date in mano ad un incapace vengono in breve tempo dilapidate, mentre date in mano ad una persona ragionevole vengono investite e si triplicano, il tempo che abbiamo è sufficiente a compiere la più grandi imprese, tant’è che Seneca afferma che “la vita è lunga, se sai farne uso”.