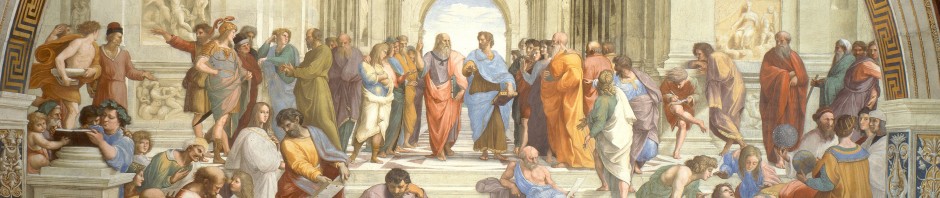Gorgia nasce intorno al 480 a.C., a Leontini, l’odierna Lentini, in provincia di Siracusa.
Le sue tre tesi principali, sono esposte nello scritto “sul non essere”, di carattere chiaramente antieleatico, e sono: a) l’essere non è, b) se anche fosse non sarebbe conoscibile, c) se anche fosse conoscibile non sarebbe comunicabile. L’essere non è perché se fosse non dovrebbe essere contraddittorio, invece l’essere non è né uno né molti, né generato né ingenerato, pertanto è troppo contraddittorio per esistere. Inoltre partendo dall’assunto che se A non è in relazione con B, allora nemmeno B è in relazione con A, Gorgia afferma che siccome il nostro pensiero ha un suo campo d’azione che non è in relazione con la realtà (posso pensare anche cose che non esistono), allora la realtà non ha nulla a che vedere col nostro pensiero, è pertanto impossibile pensare la realtà, poiché pensiero e realtà sono due cose distinte. A sostegno di questa tesi Gorgia porta anche un altro argomento, infatti noi vediamo una cosa e sappiamo che esiste anche senza sentirla, così come sentiamo un suono e non abbiamo bisogno di conferme visive o tattili per affermare che quel suono esiste, allo stesso modo se pensiamo una cosa e poniamo il pensiero sullo stesso piano dei sensi per quanto riguarda il percepire la realtà, dovremmo accettare che quello che pensiamo esiste a prescindere dal fatto che i sensi lo confermino, ma questo significherebbe ritenere esistenti il dragone o la chimera e questo è assurdo. Proprio per questo stesso motivo l’essere se anche fosse conoscibile non sarebbe comunicabile, poiché il contenuto del mio pensiero non può diventare parole, io posso dire blu e avere in mente un colore, tu puoi sentire blu e averne in mente uno simile (per convenzione) ma leggermente diverso, infatti quello che arriva a te non è un pensiero, ma un suono.
Con Gorgia siamo di fronte alla prima teorizzazione dell’impossibilità di conoscere alcunché. Si è spesso dibattuto se Gorgia sia un primo nichilista o se lui stesso non credesse a quello che diceva e quindi si trattasse di semplici giochetti retorici per dimostrare che col linguaggio si poteva dimostrare ogni cosa.
Per Gorgia il logos, la parola, può tutto. Infatti non essendoci una realtà l’uomo è libero di fare quello che vuole, se qualcosa ci fosse l’uomo sarebbe da questo qualcosa limitato, sia nell’azione, sia nell’espressione poiché sarebbe impossibile far credere alla gente quello che non è, invece in questo modo la parola può fare quello che vuole. Gorgia era infatti un abilissimo retore, per lui non contava niente la verità, ma ad importare era la capacità di argomentare, infatti un discorso ben pronunciato non va ad intaccare le capacità intellettive degli ascoltatori, ma le loro emozioni, così il fine del linguaggio non era quello di enunciare delle conoscenze, bensì quello di persuadere. Platone gli attribuirà l’affermazione secondo cui il retore riesce meglio di qualsiasi competente e Gorgia stesso, infatti, affermava che lui era più abile di suo fratello medico nel convincere i pazienti a prendere le medicine.
Da questo interesse per il linguaggio nascerà quella che viene definita eristica, ossia quella pratica che controbatte a qualsiasi affermazione dell’avversario sfruttando non tanto i concetti espressi quanto piuttosto le ambiguità del linguaggio.