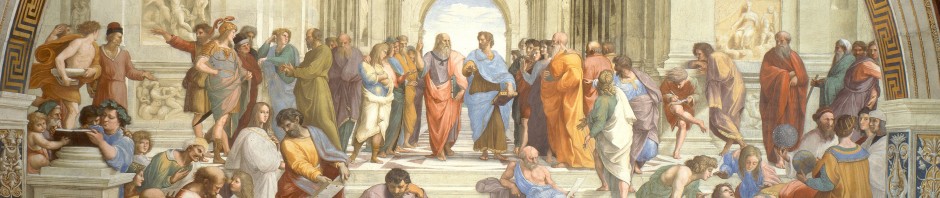La vita
Gli scritti
La figura del filosofo
La conoscenza e le idee
La città giusta
L’anima
Il Demiurgo
La morale
La vita
Nacque ad Atene nel 428-27 a.C., incontrò Socrate all’età di 20 anni e ne fu discepolo fino alla morte di quest’ultimo. Quando ad Atene s’instauro il governo dei trenta tiranni, Crizia, suo zio materno, gli chiese di farne parte, ma Platone restò deluso dal loro atteggiamento dispotico. Anche la restaurata democrazia lo deluse quando nel 399 mandò a morte Socrate e così Platone fu tra i discepoli di Socrate che temendo rappresaglie si rifugiarono a Megara, storica avversaria di Atene, presso Euclide. Nel 387 torna ad Atene e acquista i giardini dedicati all’eroe Academo, da cui diede il nome alla sua scuola che sarà appunto chiamata Accademia, dove maestro e discepoli facevano una vita in comune. Altro evento della sua vita degno di nota fu il tentativo di istruire filosoficamente Dionigi il giovane, tiranno di Siracusa, esperienza dalla quale Platone usci fortemente deluso. Morirà ad Atene nel 348-47 a.C.
Gli scritti
Platone è il primo filosofo di cui ci sono arrivati i testi conservati integralmente. Per stabilire l’ordine cronologico delle sue opere, si è partiti dalla notizia che “Le leggi” sia la sua ultima opera e poi sono stati ordinati in base alle caratteristiche stilistiche. I gruppi di appartenenza sono tre: 1) scritti giovanili, ad esempio l’Apologia di Socrate, 2) i dialoghi della maturità, ad esempio il Fedone e la Repubblica, 3) e infine i dialoghi della vecchiaia, come ad esempio il Teeteto e il Sofista. Abbiamo inoltre di Platone 13 lettere la cui autenticità è discussa, la più importante delle quali è la lettera VII che sarebbe una vera e proprio autobiografia. Platone tenta di riprodurre nei suoi scritti la tecnica di indagine socratica, infatti la forma della stragrande maggioranza dei suoi scritti è il dialogo, il metodo delle domande e delle risposte viene infatti identificato come il metodo filosofico per eccellenza. Platone distingue fra due tipi di dialoghi, quelli drammatici in cui i due protagonisti dicono direttamente le loro battute e quelli indiretti nei quali il dialogo è inserito all’interno di una cornice.
Platone tuttavia, nonostante la vasta produzione di scritti, non nutre particolare simpatia per la filosofia scritta, egli asserisce infatti che il vero luogo della filosofia è l’anima di ognuno e che il libro può avere soltanto una funzione protrettica, ossia l’esortazione dei lettori a dedicarsi alla filosofia, infatti il libro significa sempre e soltanto una stessa cosa e non può rispondere alle domande che vengono poste. Lo stesso Platone nel Fedro afferma che gli autori di uno scritto sarebbero capaci di esibire “argomenti di maggior valore” nel caso fossero chiamati a rispondere di quello che hanno scritto, allo stesso modo nel Teeteto afferma che se Protagora fosse vivo probabilmente avrebbe molte cose da ridire sulla loro confutazione della dottrina protagorea. Il vero luogo dove fare filosofia è quindi l’Accademia. Inoltre non sempre la forma dialogica è la migliore forma per spiegare un concetto filosofico, non di rado infatti nei suoi scritti Platone ricorre al mito, cioè a racconti fantastici che spiegano più o meno come dovrebbero andare le cose, questo metodo, pur essendo inferiore alla dialettica, può rivelarsi molto utile nel caso di un uditorio filosoficamente impreparato.
La figura del filosofo
Per Platone il filosofo è una figura a metà fra il sapiente (che è solo la divinità) e l’ignorante, infatti né il sapiente né l’ignorante cercano il sapere, il primo perché lo possiede, il secondo perché ignora che questo sapere esista. L’atteggiamento del filosofo deve essere quindi l’atteggiamento di chi ama quello che non ha e per questo non cessa mai di perseguire la ricerca di questo qualcosa. Nella scuola filosofica quindi non si riceve un sapere, ma si ricevono i mezzi per cercarlo, la dialettica infatti si presenta come un metodo per tenere vivo l’intelletto, irrobustirlo e permettergli così di avere il pieno controllo sulle passioni.
Con la morte di Socrate si era aperto per i suoi discepoli il problema di stabilire quale dovesse essere il ruolo del filosofo nelle città, infatti in una città ingiusta il filosofo non poteva certo lasciarsi corrompere o immischiare in una politica falsa e che ha come unico obbiettivo la contesa per il potere. Il ruolo del filosofo quindi sembrerebbe limitarsi all’indagine privata, con quella formula che nel Teeteto viene indicata come “rendersi simili al dio”, ovvero liberi nell’indagine intellettuale.
La conoscenza
Platone nel Menone analizza il problema della conoscenza. Ogni cosa può essere conosciuta o non conosciuta, ma in entrambi i casi non vi può essere alcuna ricerca a riguardo, poiché nel primo caso la si conosce e nel secondo caso non se ne sospetta l’esistenza e anche quando si trovasse qualcosa non si saprebbe se quella cosa era la cosa che si stava cercando. Una conoscenza che parte da zero quindi non è proprio possibile, bisogna ammettere l’ipotesi che ogni conoscenza per esistere deve formarsi su una base già presente. Ciò che si cerca perciò, per Platone, non è altro che qualcosa che si era già conosciuto in una vita precedente e si è dimenticato, così il compito della filosofia diventa quello di far riaffiorare questo sapere. Platone nel Menone mette in scena uno schiavo che non sapendo nulla di matematica arriva a dimostrare il teorema di Pitagora, l’apprendimento altro non è dunque che un processo di reminiscenza (anamnesi). Sempre nel Menone Platone definisce la scienza (epistheme) come quel ragionamento capace di distinguere tra vero e falso e che sa rispondere alla domanda “perché”, quindi è in grado di indicare le cause di un qualcosa. La conoscenza si distingue dall’opinione vera poiché pur giungendo allo stesso risultato l’opinione vera non sa rendere ragione del perché di una cosa.
Una scienza per essere tale non può non essere vera, pertanto Platone afferma che gli oggetti sensibili non possono essere oggetto di scienza per via della loro mutevolezza, i sensi quindi non sono validi ai fini della scienza.
Se vedo due oggetti molto simili posso dire che sono uguali pur riconoscendo che non lo sono completamente. Cosa mi permette di fare ciò? Il richiamo all’uguale in se, che Platone definisce con il termine “idea”, mai riscontrabile nella realtà ma tuttavia presente nel nostro intelletto. Le idee sono fondamentali per la reminiscenza, la realtà sensibile infatti risveglia al nostro interno il ricordo delle idee che quindi diventano il criterio con cui valutiamo la realtà. L’idea è quindi un universale, mentre gli oggetti sensibili sono singoli casi dell’universale, io sono un uomo, tu sei un uomo, ma nessuno di noi due è l’uomo in se. L’artigiano quindi non fa altro che fissarsi in mente un’idea e forgiare un materiale sulla base di quell’idea che s’è fissato in mente.
Ma cosa rappresenta esattamente l’idea? Perché un letto, a prescindere dalle mille forme, colori e cose varie, è pur sempre un letto? Secondo Platone si deve rintracciare il motivo per cui una cosa è in un determinato modo piuttosto che in un altro nel fine per cui quella cosa esiste, un letto perciò può essere quadrato, rettangolare, giallo, rosso, ma non può essere pieno di spuntoni, poiché altrimenti non può essere classificato come letto non potendo adempiere al fine per cui un letto viene pensato. In questo senso l’idea è la causa delle cose, in grado di spiegare perché sono in un determinato modo e non in un altro e per questo motivo può essere oggetto di scienza. Questa spiegazione sarà chiamata finalistica o teleologica.
Platone divide gli oggetti della conoscenza in due gruppi: oggetti sensibili, ossia coglibili tramite i sensi, e oggetti intelligibili, ossia coglibili attraverso l’intelletto. Ad ognuno di questi due gruppi, a sua volta, ne appartengono altri due: alla conoscenza sensibile appartengono l’eikasia, ossia la conoscenza di immagini generate da oggetti sensibili su superfici riflettenti, e la pistis, ossia la “credenza”, la conoscenza degli oggetti sensibili veri e propri, probabilmente chiamata così perché solitamente a questi oggetti che si dà credibilità, entrambi questi due tipi di conoscenza formano il piano della doxa, dell’opinione. Alla conoscenza intelligibile appartengono invece la dianoia, ossia la conoscenze che procede attraverso passaggi propria delle conoscenze matematiche, e la noesis, conoscenza vera e propria delle idee. Platone individua dei limiti alla matematica, infatti, nonostante giunga a conclusioni che riguardino l’universale, si serve tuttavia di rappresentazioni sensibili degli oggetti che studia, inoltre i matematici si servono di ipotesi evidenti di per se a chiunque e da lì poi discendono ad una serie di conclusioni, mentre la dialettica parte da un’ipotesi non per discendere ma per giungere ad una conclusione superiore fino al raggiungimento di un principio non più ipotetico che Platone ravvisa nell’idea di bene.
Platone paragona la funzione del bene per le cose intelligibili alla funzione del sole per le cose sensibili, infatti così come il sole con la sua luce rende possibile vedere le cose sensibili, allo stesso modo il bene essendo verità fa sì che le cose intelligibili siano conoscibili, inoltre così come il sole col suo calore è condizione essenziale per la vita, allo stesso modo il bene è condizione essenziale per l’essere delle idee. Il bene è quindi causa delle idee e in quanto causa è superiore ad esse, poiché ciò che è causa è superiore visto e considerato che senza di questa causa le altre cose non potrebbero esistere.
Platone per spiegare questi gradi della conoscenza racconta il famoso mito della caverna: lui immagina che ci siano degli individui legati in una caverna, costretti a guardare il fondo di questa caverna, alle loro spalle vi è un muretto e dietro il muretto un fuoco. Su questo muretto vengono fatte passare delle statuine che riflettono la loro ombra sul fondo della caverna, quelle ombre per gli uomini imprigionati sono l’unica realtà esistente. Un giorno un uomo riesce a liberarsi, allora andando verso l’uscita della caverna, scopre le statuine e si rende conto che quella che lui aveva fino a quel momento ritenuta realtà era solo un’imitazione delle statuine. Non contento continua ad andare verso fuori, uscito dalla caverna vede i cavalli, gli alberi e capisce che quelle statuine non erano altro che una riproduzione di altri oggetti più alti, poi finalmente alza lo sguardo al cielo e resta abbagliato dal sole. Quando torna dentro la caverna cerca di far capire ai compagni che la realtà non è quella che hanno lì davanti, ma non gli credono e lo ammazzano, un po’ com’era stato per Socrate. I filosofi quindi hanno il diritto di governare poiché sono gli unici a conoscere l’idea del bene e come aveva sostenuto Socrate chi sa cos’è il bene non può non farlo.
Platone polemizzò duramente con Antistene, il quale sosteneva che dai nomi si potesse giungere alle idee, infatti Platone sosteneva che i nomi non sono altro che uno strumento per distinguere la sostanza delle cose, ma come tutti gli strumenti possono essere fatti bene o male e per capire quanto siano adeguati al loro compito bisogna essere in possesso del criterio che consente di farlo, bisogna quindi conoscere l’idea, per Platone allora è dall’idea che si arriva ai nomi e non viceversa come aveva sostenuto Antistene.
Oltre a negare i nomi come possibile via per la conoscenza, Platone nega anche la possibilità che questa via sia la conoscenza sensibile, lo vediamo nel Teeteto, dove la prima affermazione di Teeteto secondo cui sensazione è conoscenza viene paragonata alla celebre affermazione di Protagora secondo cui l’uomo è misura di tutte le cose. In questo modo sarebbe impossibile dire il falso, ma ciò per Platone non è accettabile, anche perché se tutte le opinioni sono vere dovrebbe esser vera anche quella secondo cui tutte le opinioni sono false. Diventa allora necessario distinguere tra vero e falso. Sempre nel Teeteto la conoscenza viene prima paragonata ad una tavoletta di cera su cui si imprimono delle conoscenze e l’errore consisterebbe in questo caso nello scambiare una percezione con una precedentemente avuta, ma siccome l’errore è possibile farlo anche su realtà non sensoriali come ad esempio i numeri, la conoscenza viene allora paragonata ad una voliera dove vengono rinchiusi gli uccelli (conoscenze) e l’errore consisterebbe nell’afferrare l’uccello sbagliato fra tutti quelli disponibili. Resta però aporetico il dialogo in quanto se io ho una conoscenza, quindi conosco una determinata cosa, come posso scambiarla per qualcos’altro conoscendola?
Il rapporto tra le idee e gli oggetti sensibili è problematico. Platone ne parla nel Parmenide, dove stavolta è Parmenide che fa delle domande a Socrate. Se ammettiamo che l’idea è presente integralmente nell’oggetto sensibile allora questa cessa di esistere per sè, se invece ammettiamo che una parte dell’idea è presente nell’oggetto sensibile allora l’idea non sarebbe più unitaria ma si disperderebbe nella molteplicità degli oggetti sensibili. Anche la tesi secondo cui gli oggetti sensibili sono tali perché partecipano dell’idea viene meno poiché la partecipazione presuppone una somiglianza tra l’idea e l’oggetto sensibile, ma questo significa forse che l’idea di bellezza e bella? Ma allora l’idea di molteplicità e molteplice? No, non può essere. Si pone quindi il problema del rapporto tra uno e molti. L’indagine trova svolgimento nel Sofista, in cui Platone identifica quelli che lui chiama “sommi generi”, ovvero idee generalissime come essere, moto, quiete, identico e diverso che sono idee generalissime poiché sono predicabili di ogni cosa. Tuttavia dire che il moto o la quiete sono, non significa dire che sono l’essere, altrimenti viene fuori che moto e quiete sono la stessa cosa, quindi io posso dire che la quiete è e che la quiete non è il moto, il non essere quindi esiste, a differenza di come aveva sostenuto Parmenide. Precisamente esiste nella forma di “essere diverso da”, il non essere e l’essere quindi non sono contraddittori come moto e quiete, ma stanno nello stesso rapporto di, ad esempio, non grande e grande. Platone teneva particolarmente a salvare l’esistenza del non essere, poiché se si dava per buona l’affermazione di Parmenide secondo cui il non essere non esiste e non si può né dire né pensare, allora veniva meno la possibilità di dire il falso e assieme a questa perdeva senso la ricerca del sapere, obbiettivo della filosofia.
Per Platone era sbagliato definire l’essere come ciò che è corporeo, ovvero la posizione materialista, poiché se il materialista poteva tranquillamente affermare che anche l’anima era materia, si trovava in difficoltà al momento di affermare se era essere la giustizia, in quanto se lo era doveva essere fisicamente da qualche parte, mentre se non lo era non si poteva distinguere tra uomo giusto e ingiusto. Altrettanto sbagliata era la posizione di coloro che ritenevano che l’essere fossero le idee incorporee e che fossero estranee ad ogni movimento, infatti, Platone riprende la definizione materialista secondo cui essere è tutto ciò che può fare o subire un’azione anche solo una volta e arriva a dire che essere conosciute equivale a subire un’azione e pertanto anche le idee erano dotate di movimento, essere e divenire non erano più per Platone due realtà opposte come aveva affermato Parmenide, si trattava perciò di scoprire quali relazioni collegavano fra di loro le idee poiché non potevano essere tante realtà scollegate fra di loro ed è alla dialettica che appartiene il compito di rintracciare queste relazioni.
La dialettica diventa così da mero strumento di discussione, un vero e proprio strumento d’indagine costituito da due fasi: la prima, synagoghè, consiste nel ricondurre una molteplicità ad un unità e la seconda, diaresis, consistente nel dividere un’idea unitaria nelle sue specie o articolazioni. Nel Sofista, Platone fa l’esempio della pesca: se si vuole definire che cos’è la pesca si dovrà prima risalire ad una categoria più grande che la comprenda (la tecnica) e poi a poco a poco, proseguendo per diramazioni, rintracciare tutti i tratti salienti che caratterizzano le pesca. Compito del dialettico sarà quindi quello di rintracciare tutti i possibili rapporti fra le idee, che non sono tutte in relazione fra loro poiché altrimenti il moto sarebbe in relazione con le quiete e viceversa e nemmeno sono mondi a se stanti perché altrimenti non si potrebbero formulare proposizioni sensate alle quali attribuire i valori di vero e falso: è infatti di fronte all’affermazione “io parlo” che posso dire se è vera o no, e non soltanto di fronte ad “io” oppure “parlo”. Il dialettico quindi sarà sempre in grado di distinguere tra vero e falso poiché saprà sempre riconoscere le relazioni sussistenti fra le idee.
La città giusta
Platone si impegna ad esaminare le città per capire su cosa dovrebbe fondarsi una città giusta, che piuttosto che uccidere Socrate riconoscesse in lui l’unico degno di governarla. Nella Repubblica, Platone individua come base della città la divisione dei mestieri, in quanto non tutti gli individui sono uguali e ciascuno è più portato di altri per un determinato compito, l’ingiustizia si genera allora quando qualcuno non fa quello che dovrebbe fare oppure pretende di fare qualcosa che non gli compete. Platone suddivide i cittadini della città giusta in tre classi: 1) quella degli artigiani, finalizzati alla creazione dei beni necessari per mandare avanti la città, 2) quella dei guerrieri, addetti alla difesa della città, 3) e quella dei filosofi, unici in grado di governarla poiché in grado di distinguere tra bene e male e di conseguenza, socraticamente, giusti. Platone individua anche i fattori che avevano fino a quel momento impedito la giusta ripartizione dei doveri, questi sono la ricchezza e la famiglia, infatti la famiglia genere quel meccanismo perverso per cui ognuno aspira alla migliore posizione per i propri figli a prescindere dalle doti che la natura ha dato a questi. Platone quindi ipotizza l’eliminazione della famiglia: nella città giusta di Platone i figli venivano allontanati dai genitori alla nascita, così che nessuno avrebbe poi saputo quali erano i propri figli e i propri genitori e a ciascuno sarebbe stato dato il ruolo più adatto. Per Platone perde anche valore la differenza biologica fra uomo e donna, così che lui non esclude la possibilità di donne guerriero o filosofe. Le ricchezze sarebbero state eliminate per il gruppo dei filosofi e dei guerrieri, che avrebbero campato a spese della città in cambio dei servigi offerti, mentre sarebbero state mantenute per gli artigiani ma senza permettere alcun accumulo spropositato. Per accertare le doti naturali di ogni singolo individuo, per Platone l’unico mezzo è l’educazione. Guerrieri e filosofi dovranno quindi inizialmente ricevere un addestramento alla ginnastica e alla musica, ovvero all’addestramento del corpo e al carattere. Con musica Platone intende anche la poesia, anche se si dimostra tremendamente critico nei confronti di quest’ultima, infatti egli afferma che la poesia è una sorta di follia ispirata, il poeta pertanto non conosce quello che dice, poiché non fa altro che ripetere le parole della musa. Platone non esclude totalmente l’utilità della poesia ma afferma che nella città giusta sarebbe stata ammessa soltanto quella poesia che avrebbe consentito un’educazione morale dei cittadini. Di questi giovani, poi, soltanto quelli che avrebbero dimostrato particolari capacità intellettive sarebbe stati introdotti gradualmente alla filosofia.
Nella vecchiaia però Platone si distanzia nettamente dal modello di città proposto nella Repubblica, probabilmente essendosi reso conto del fatto che era un modello utopico. In un trattato, il Politico, Platone afferma che il vero uomo politico dev’essere dotato di sapere e non è corretta la definizione del politico come pastore, perché è piuttosto un tessitore. Con un uomo politico sapiente si può anche fare a meno delle leggi, così il politico potrebbe analizzare ogni singolo caso come un medico fa con i pazienti e non verrebbero tutti giudicati sulla base di leggi uguali per tutti. Nelle Leggi invece Platone, aggiornando ancora una volta il suo pensiero, afferma che constatato il rifiuto di tutti di dare il governo in mano ai filosofi, diventa necessario in una città un corpo di leggi, per far si che i dettami filosofici vengano espressi sotto forma di leggi costrittive, inoltre vengono riammesse la famiglia e la proprietà privata, sostenendo che ad ogni nucleo familiare dovessero spettare due appezzamenti di terra inalienabili, inoltre il dovere di difendere la città viene nelle Leggi esteso a tutta la cittadinanza e non più soltanto ai guerrieri.
La democrazia veniva identificata da Platone come una sorta di anarchia poiché era refrattaria a porre dei limiti alle libertà personali.
L’anima
Nel Fedone, Platone cerca di dimostrare che l’anima sia immortale, infatti se l’anima ha dimenticato la conoscenza che aveva acquisito, significa che l’anima preesisteva prima di incarnarsi in un corpo e doveva avere la stessa natura degli oggetti che conosceva, ossia le idee che sono ingenerate e incorruttibili. Inoltre l’anima partecipa dell’idea di vita, così come il tre partecipa dell’idea di dispari, e quindi non potrà mai accogliere al suo interno l’idea di morte, così come il tre pur non essendo il dispari in se non potrà mai accogliere al suo interno l’idea di pari. Altra prova, portata da Platone nel Fedro, parte dall’assunto che ciò che si muove sempre è immortale, ma soltanto ciò che si muove da se può muoversi sempre, perché altrimenti se dovesse cessare il moto principale cesserebbe anche il suo, ciò che si muove da sè è principio e se è principio dev’essere ingenerato, altrimenti non sarebbe principio. L’anima è pertanto questo principio di movimento, quindi ingenerato, che si muove eternamente.
Rispetto al Fedone, dove l’anima veniva vista come un principio unitario identificato con l’intelletto, nella Repubblica Platone introduce una tripartizione dell’anima, adesso l’anima è formata da tre parti: 1) quella appetitiva, con sede nei visceri, 2) quella animosa, con sede nel cuore e 3) quella razionale, con sede nel cervello. Identificando ciascuna di queste tre parti con una delle classi della città giusta, così come per la città, anche per l’anima la giustizia consisteva nel far si che ogni parte facesse quello che le era dato di fare, soltanto quindi alla parte razionale spetta il governo dell’intera anima. Nel Fedro Platone paragona l’anima ad una biga alata, trainata da due cavalli, uno bianco e arrendevole e uno nero e animoso, corrispondenti rispettivamente alla parte appetitiva e alla parte animosa dell’anima, la biga era ovviamente la ragione. Quando i cavalli si oppongono ai comandi dell’auriga allora l’anima viene attraversata da conflitti che le impediscono di agire in modo unitario.
Il Demiurgo
Del mondo fisico, caratterizzato da instabilità non si può avere scienza, Platone perciò si limita a raccontare un mito per spiegare come verosimilmente è nato: è il mito del Demiurgo, l’architetto divino del mondo che come un artigiano ha plasmato quella che poi Aristotele avrebbe definito materia e che Platone definisce un quid (quid = qualcosa, latino) avendo in mente come progetto le idee ed avendo come fine il meglio. In quanto creazione il mondo non può essere perfetto come il modello sulla cui base è stato creato ed è per questo che è caratterizzato da continui fenomeni di aggregazione e disgregazione. Platone parla anche di anima del mondo, sostenendo che il Demiurgo per dare ordine a tutto il creato avesse dotato il mondo stesso di un’anima intelligente, così che il mondo si caratterizzi come un grande essere vivente.
La morale
Platone critica Aristippo e la scuola cirenaica per via dell’equivalenza da loro istituita fra bene e piacere: bene e male sono contraddittori e si escludono a vicenda, mentre piacere e dolore non si escludono a vicenda, è evidente quindi che poiché il rapporto che intercorre tra le due cose è differente il piacere deve essere diverso dal bene e il male dal dolore.
In uno dei suoi ultimi dialoghi, il Filebo, Platone tenta di trovare il bene in relazione all’uomo e non più il bene in se. Egli afferma che il bene non può essere solo ed esclusivamente il piacere, in quanto senza riferimento all’intelligenza non si potrebbe neanche capire che si sta provando piacere, tuttavia ciò non significa che una vita buona dev’essere una vita soltanto di scienza, anche l’attività conoscitiva infatti può essere piacevole. La vita buona consta di un giusto miscuglio di intelligenza e piaceri, ma non tutti i piaceri, bensì quelli legati alla conoscenza, alla vista e all’udito in quanto sono slegati dal soddisfacimento di bisogni e sono pertanto separati dal dolore: sono questi piaceri che devono entrare a far parte di quella che Platone chiama vita mista.
La virtù, capace di generare il bene dell’anima secondo la necessarietà posta da Socrate fra vita etica e sapere non può essere appresa nella città, che Socrate l’aveva condannato a morte, ma nella scuola filosofica.