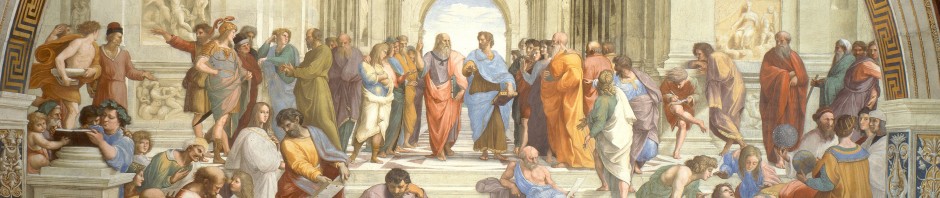A partire dalla metà del V secolo in Grecia si diffuse la figura del sofista, termine che letteralmente significa “colui che fa professione del proprio sapere”. Niente di nuovo, verrebbe da dire, poiché ogni mestiere si fonda sul sapere qualcosa che gli altri non sanno e farsi pagare per farla al posto loro. Ma i sofisti si presentavano come possessori di un sapere particolare, che permetteva di eccellere nella vita pubblica e privata, i sofisti si presentano quindi come maestri di virtù, in greco ἀρετή (aretè). È quindi con i sofisti che nasce la figura dell’insegnante, anche se in maniera un po’ contraddittoria: si proponevano di insegnare a vivere in democrazia, ma poi, gli alti compensi richiesti, facevano si che soltanto le famiglie aristocratiche potessero pagare la formazione del figlio presso un sofista.
Protagora, il più famoso dei sofisti, nacque intorno al 480 ad Abdera, città della Tracia. La sua tesi più famosa è quella secondo cui “l’uomo è misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono, di quelle che non sono in quanto non sono”. Col termine “uomo” è probabile che Protagora non intendesse tutto il genere umano, ma piuttosto il singolo individuo, in quanto unico arbitro della sua verità, infatti al sano il miele appare dolce, al malato appare amaro, ma non esiste un terzo criterio che ci dice se il miele è in se dolce o amaro e le due sensazioni si equivalgono sul piano della verità. Ogni cosa, pertanto, è a seconda di come appare a chi la percepisce e niente è in se. Infatti a proposito della divinità Protagora dice “Riguardo agli dei non ho la possibilità di accertare né che sono né che non sono, opponendosi a ciò molte cose: l’oscurità dell’argomento e la brevità della vita umana”, infatti poiché degli dei non si ha alcuna esperienza sensibile, non è possibile affermare nulla su di loro, poiché l’uomo non può essere misura di quello che non percepisce.
Lo stesso criterio di verità è valido al livello etico. Ma allora come può il sofista presentarsi come maestro? Come può farsi pagare per dispensare un sapere puramente soggettivo? Nell’autodifesa che Platone mette in bocca a Protagora nel Teeteto, Protagora paragona il mestiere del sofista a quello del medico, infatti è vero che il miele può apparire dolce o amaro a seconda dello stato di salute di chi lo assaggia, ma è anche vero che tutti concordano sul fatto che la salute è obbiettivamente meglio della malattia, il sofista perciò non contrapporrà vero a falso, in quanto ogni singola opinione è vera per colui che la pronuncia, ma contrapporrà l’utile al dannoso, curerà quindi lo stato di malattia mentale che fa percepire come utili cose che in realtà non lo sono sia sul piano dell’individuo, sia sul piano della città. Assume in questo modo notevole importanza il linguaggio, che cessa così di essere un semplice strumento comunicativo e diventa esso stesso oggetto d’indagine e d’insegnamento.
Non pronunciandosi per quello che riguarda gli dei, Protagora caratterizza l’uomo a partire dagli animali: egli riconosce l’inferiorità dell’uomo sul piano delle doti naturali, ma dice anche che questa inferiorità è stata compensata nell’uomo dalle tecnich; la tecnica più alta è la tecnica politica, che sta alla base di una città e che la città si impegna a tramandare prima con l’insegnamento e poi con le leggi.