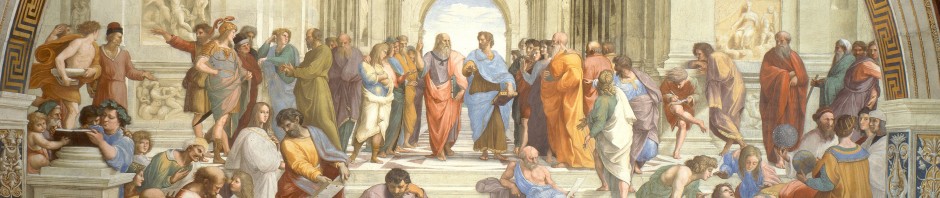Pitagora nacque a Samo nel 540-535 a.C., fu costretto ad emigrare a causa del tiranno Policrate ostile al vecchio domino degli aristocratici di cui lui faceva parte e andò in Magna Grecia a Crotone, dove fondò una comunità caratterizzata da una vita condotta in comune sebbene non si possa ancora parlare a proposito di questa comunità di scuola filosofica. Costretto ad andarsene anche da Crotone, trovò la morte nel 497-496 a.C. a Metaponto.
È da notare come Aristotele nel libro A (alpha) della Metafisica, si riferisca a tutti gli altri filosofi singolarmente, mentre soltanto nel caso dei pitagorici si riferisce all’intera setta. È probabile che Aristotele si riferisca ad una filosofia pitagorica d’età avanzata, infatti il nucleo centrale dell’insegnamento pitagorico era impartito a voce e vi era una regola che imponeva il silenzio riguardo alle dottrine apprese con coloro i quali non facevano parte della comunità, soltanto successivamente con Filolao e Archita si ebbe una prima messa per iscritto della filosofia pitagorica.
Attorno alla figura di Pitagora si sviluppò un notevole culto della personalità, è infatti in ambiente pitagorico che nasce l’espressione “ipse dixit”, ovvero “l’ha detto lui stesso”, la parola di Pitagora , infatti, non poteva essere messa in discussione e anche dopo la sua morte si continuò a sostenere che fosse lui a parlare, per questo motivo non possiamo sapere se il famoso teorema di Pitagora sia stato veramente scoperto da lui o da un suo discepolo.
I membri della comunità dovevano essere iniziati e l’insegnamento era forse impartito gradualmente, secondo il modello dell’iniziazione ai misteri. Il primo livello era quello degli akoùsmata, ovvero coloro che potevano soltanto ascoltare quanto veniva detto, principalmente si tratta di precetti da seguire, come ad esempio l’astensione dal mangiare carne. Nelle fasi successive si veniva iniziati alle forme di sapere più alte: matematica, geometria, musica e astronomia.
Le dottrine formulate dai pitagorici sono essenzialmente due. La prima è quella della trasmigrazione delle anime ed è di chiara derivazione orfica: l’orfismo sosteneva che in principio vi era stato un peccato e che la pena da scontare fosse la permanenza dell’anima in un corpo, così attraverso un susseguirsi di morti e reincarnazioni si sarebbero riunite tutte le parti nel tutto, a questo scopo venivano praticate delle tecniche di purificazione come il vegetarianismo e così via. Per i pitagorici però, al compiere riti e vivere in modo giusto, bisognava aggiungere la conoscenza dei numeri.
La seconda grande dottrina che Aristotele attribuisce ai pitagorici è quella secondo cui i numeri sono l’essenza della realtà e la realtà imita i numeri, infatti il numero è l’unico modo per interpretare la realtà, poiché tutto è misurabile e tutto è esprimibile secondo rapporti. Per capire questa loro affermazione occorre fare ricorso a come erano soliti compiere i calcoli i greci, infatti si servivano di psèphoi, ovvero sassolini mediante i quali i numero erano rappresentati visivamente. In questa loro visione assumeva un ruolo fondamentale il numero 1, infatti l’aritmetica antica non conosceva lo 0, così l’1 era il numero prima del quale non vi era nulla, era la sorgente degli altri numeri, poteva far diventare un pari dispari e viceversa e pertanto veniva definito “parimpari” supponendo che includesse in se sia il pari sia il dispari. I pitagorici svilupparono anche una concezione mistica dei numeri, infatti assimilarono il 2 alla donna e il 3 all’uomo, così il 5 veniva ad essere simbolo del matrimonio; il 10, invece, era il numero che raffigurava l’universo, in quanto somma dei primi 4 numeri che rappresentavano in ordine il punto, la linea, la superficie e il solido, la tetrattide (una piramide con la base di 4 sassolini) raffigurava quindi la successione delle tre dimensioni che caratterizzano l’universo fisico; il 4 o il 9 invece potevano essere assunti a simbolo della giustizia poiché quadrati rispettivamente del primo numero pari e del primo numero dispari. La conoscenza quindi, per i pitagorici, consisterà nella ricerca dei rapporti numerabili esistenti fra le cose.
Altro aspetto interessante, anche se secondario, è la cosmologia pitagorica, infatti secondo i pitagorici al centro dell’universo c’è un focolare attorno al quale girano la terra, il sole e gli altri pianeti. Questa concezione è importante poiché per la prima volta la terra viene espropriata della propria posizione al centro dell’universo.