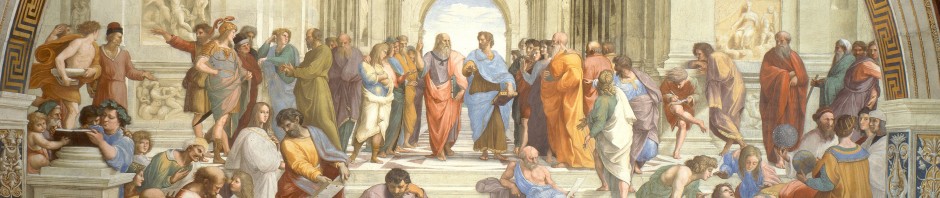Di Gregorio di Nissa ci sono pervenute una serie di opere scritte tra il 381 e il 384. Il Dialogo sull’anima e sulla resurrezione è un dialogo, sul modello del Fedone platonico, in cui egli fa parlare la sorella morta sul destino delle anime, sulla morte e sulla resurrezione. La sua opera teologica più importante resta comunque il Discorso catechetico grande composto tra il 386 e il 387.
Gregorio è un ammiratore di Origene, da cui riprende la tecnica dell’interpretazione allegorica del testo sacro, sebbene la riprenda con maggior cautela.
Pur non nutrendo grande fiducia nelle capacità conoscitive umane, egli non ritiene che fede e regione siano due cose totalmente distinte. Egli riprende dal platonismo il dualismo tra mondo intelligibile e mondo sensibile, affermando che tutto ciò che è nel mondo sensibile, compreso l’intelletto umano, non può raggiungere mai quello intelligibile. Tuttavia egli afferma che nel mondo sensibile sono presenti delle tracce di Dio attraverso cui l’uomo può arrivare ad avere una conoscenza parziale di Dio.
Nonostante ammirasse Origene, egli se ne discosta per quanto riguarda la teoria della creazione, infatti per Origene era continua, mentre per Gregorio è istantanea e fuori dal tempo, in un unico istante Dio ha posto i semi di tutte le cose, le quali poi si sono sviluppate secondo la propria natura.
Gregorio rifiuta la dottrina stoica della conflagrazione poiché rifiuta l’idea che nel mondo esista qualcosa che lo porterà a distruggersi, tuttavia accetta che il mondo possa finire per volere di Dio.
Le cose, così come sono attualmente, non sono il frutto della creazione diretta di Dio, l’uomo, in particolare, era stato creato a sua immagine e somiglianza, era stato creato quindi come archetipo, idea-modello, dell’uomo perfetto in senso platonico, ossia libero e razionale. L’uomo attuale è quindi frutto di una seconda creazione in previsione del peccato e della caduta, dovuti alla libertà propria dell’uomo, è soltanto in questa seconda creazione che appare la distinzione fra uomo e donna. L’uomo è quindi una creatura a metà tra la divinità, razionale, e gli animali, irrazionali. Il Logos incarnandosi ha voluto ristabilire lo stato originale dell’uomo.