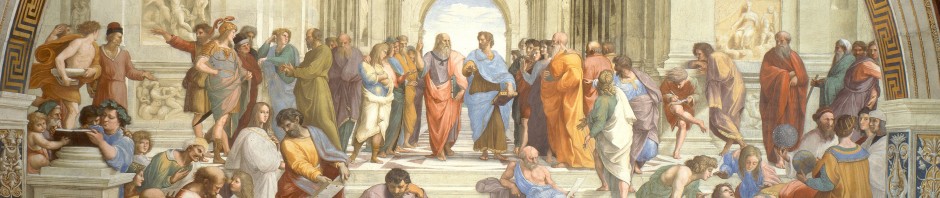La vita e le opere
La concezione della filosofia
L’Uno
Le ipostasi: il Nous, l’anima, la materia
L’estasi
La Vita e le opere
Plotino nacque a Licopodi in Egitto verso il 204, iniziò tardi ad occuparsi di filosofia, verso i 28 anni, ad Alessandria dove incontrò il platonico Ammonio Sacca e del quale seguì gli insegnamenti per 11 anni. Nel 44 si sposta a Roma dove raccolse attorno a se un gruppo di amici e discepoli con i quali leggeva e commentava i testi di Platone, Aristotele e dei loro commentatori. Plotino compose un totale di 54 trattati, da notare che è il primo autore dell’antichità che scrive di suo pugno e non detta ad un amanuense. Questi trattati ci sono giunti nella loro versione integrale in un’edizione curata dal suo allievo Porfirio che li divise in sei gruppi da nove da cui il nome Enneadi, raggruppandoli per temi seguendo l’itinerario del filosofo che s’innalza fino a raggiungere la divinità. I testi di Platone sono il punto di partenza della sua filosofia, che egli intendeva essenzialmente come esplicazione di ciò che era implicito nei testi di Platone, arrivando però così a darne una lettura del tutto originale.
La concezione della filosofia
Per Plotino il filosofo è colui che realizza la convergenza di due modi di concepire l’attività filosofica: il primo è quello canonico dell’insegnamento e della discussione praticata con discepoli e amici, il secondo è l’esercizio di una riflessione personale che si realizza pienamente soltanto attraverso il ripiegamento in se stessi. Porfirio comincia la sua biografia di Plotino scrivendo che questo era “come uno che si vergogni di essere in un corpo”, questa sua vergogna non era dovuta al corpo in sè, quanto piuttosto al fatto che questo corpo fosse soggetto al sortilegio del mondo. Plotino si discosta dallo gnosticismo che riteneva il mondo un male, egli infatti lo paragona ad un’opera d’arte le cui parti prese singolarmente non sono nulla, ma è il tutto che ha valore. Egli crede che il corpo e gli stessi demoni, quanto più sono vicini alla terra, tanto più sono inseriti in una catena d’influssi generata dal fatto che tutte le cose sono fra loro collegate. Per Plotino ogni cosa è pienamente se stessa quando è una e non si perde nella molteplicità. Pertanto solo chi esercita la teoria, ossia la contemplazione, è uno e fa tutt’uno col proprio oggetto. L’obbiettivo della filosofia è quindi la realizzazione di quella contemplazione che nella vita è presente solo in piccole parti, allontanandosi dal corpo e da tutto ciò che continua a legare alla molteplicità per arrivare a fare essere l’io L’uno e non più UN uno.
Plotino dimostra la superiorità della contemplazione rispetto a qualsiasi azione mediante il concetto di fine, infatti la contemplazione è il fine a cui mirano tutte le azioni, anche l’azione di un artigiano è guidata dalla volontà di contemplare l’oggetto prodotto. Aristotele aveva definito la contemplazione una sorta di prassi, mentre per Plotino, al contrario, le azioni e le attività produttive sono forme deboli di contemplazione.
L’Uno
Plotino riprende da Platone la struttura gerarchica della realtà, al vertice di questa struttura egli mette l’Uno. Plotino elabora una teologia negativa: l’Uno è ineffabile e di lui si può parlare solo per negazioni, il termine Uno pertanto è quello che lo definisce meglio in quanto ci dice che l’Uno non è molteplice. Sbagliava, quindi, Platone a definirlo Bene poiché in questo modo lo stava già definendo in rapporto alle altre cose. Per spiegare come da questo principio unitario possa venire fuori tutta la realtà Plotino si serve di due concetti complementari fra loro, questi sono emanazione e processione. Per quanto riguarda il termine emanazione si può fare il paragone con una candela accesa, all’interno di una stanza buia, che emana luce. Da questo primo paragone possiamo già percepire alcune caratteristiche di questa creazione, l’azione dell’Uno infatti non è né necessaria né libera, è spontanea, ossia l’Uno agisce seguendo la sua natura. Inoltre nell’Uno vi è sovrabbondanza di essere, è una fonte illimitata di essere, infatti l’Uno emanando l’essere non diminuisce se stesso. Per quanto invece riguarda il termine processione, Plotino fa un secondo paragone con la fonte e il ruscello. Rispetto al paragone con la candela, il secondo paragone introduce altri due concetti fondamentali: il primo è che pur essendo diversa la fonte dal ruscello, non esiste una vera e propria differenza se non in termini di quantità (nella fonte c’è più acqua che nel ruscello, ma l’acqua che c’è nella prima è identica a quella presente nel ruscello), il secondo è che è possibile individuare una cronologia logica di questa processione.
Riprendendo Aristotele, Plotino riconosce che ogni atto creativo è l’esito di un atto teoretico, così come l’artigiano produce la sedia soltanto dopo averla pensata, pertanto anche l’Uno deve pensare ed esattamente deve pensare a se stesso. In parole povere l’Uno si autointuisce e emana la realtà, in questa sua azione teoretica, tuttavia, pensante e pensato non sono distinti nemmeno concettualmente.
Le ipostasi: il Nous, l’anima, la materia
La prima “tappa” (Plotino le chiama ipostasi) di questa creazione è il Nous, ovvero l’intelletto. Anche il Nous ha una sua attività produttiva simile a quella dell’Uno, egli pensa a se stesso e fa derivare un’ipostasi successiva. In questa sua attività, tuttavia, il Nous si distingue dall’Uno e si identifica con il pensiero di pensiero aristotelico dove soggetto e oggetto sono concettualmente distinti: il Nous come oggetto corrisponde per Plotino al mondo delle idee platonico. Le idee non sono più, quindi, entità a sè stanti, superiori perfino alla divinità, infatti il Demiurgo non aveva alcun potere su di loro e poteva solo adeguarsi ad esse per copiarle, ma esistono nella misura in cui vengono pensate dalla divinità. Le idee quindi esistono indipendentemente dalla nostra attività conoscitiva, ma non indipendentemente da quella del Nous. Se quindi Platone nell’Eutifrone affermava che le cose sante piacciono agli dei perché sono sante, Plotino afferma che le cose sono sante proprio perché piacciono agli dei.
Dal Nous deriva l’anima. L’Uno era unità, il Nous era “doppio”, l’anima è la totale molteplicità: essa agisce come uno specchio rotto che moltiplica le immagini delle idee create dal Nous all’infinito, così se nel Nous vi era un’unica idea di cavallo, nell’anima vi saranno infinite idee di cavallo, bianco, nero, grosso, piccolo e così via. Si tratta quindi di un anima universale, quella che Platone aveva definito anima del mondo, da cui si genera il mondo sensibile e le anime di ogni singolo uomo. Ogni singola idea presente nell’anima si va ad incarnare nella materia dando vita agli oggetti sensibili.
Ma cos’è la materia per Plotino? La materia per Plotino non esiste, egli infatti riprendendo il paragone fatto con la candela afferma che la materia è là dove non arriva l’emanazione dell’Uno, ossia non c’è, mancando la materia manca anche il male di cui la materia secondo una concezione ampiamente diffusa sarebbe il principio. Tuttavia il male nel mondo esiste e Plotino lo individua come una direzione autodiminuitiva che l’uomo può intraprendere, il grande matematico ad esempio può mettersi a fare calcoli semplici, cosa di che di per se non è male ma che lo diventa se si considera che quell’uomo potrebbe fare di meglio.
L’estasi
L’uomo è l’unica creatura capace di ripercorrere a ritroso questa strada che adesso abbiamo percorso in discesa, obbiettivo dell’uomo è quello di ritornare all’uno. L’anima umana infatti può guardare verso il basso, quindi verso la materia, oppure può guardare verso l’alto, quindi verso l’intelletto e conformarsi ad esso. Si arriva a in questo modo alla contemplazione, all’essere tutt’uno con le idee oltre il livello della coscienza, in tal senso la conoscenza è tanto maggiore quanto meno se n’è consci. Il livello maggiore che si può raggiungere è quello dell’“intelletto in amore” in quanto l’amore mira alla bellezza, propria delle idee, raggiunto questo stato si può soltanto aspettare l’estasi che porta ad una piena assimilazione all’Uno, nell’estasi l’uomo annulla se stesso per diventare un tutt’uno con l’Uno. L’estasi non sostituisce l’attività filosofica, ma è piuttosto il coronamento di questa. Porfirio ci dice che Plotino raggiunse questo stato quattro volte.