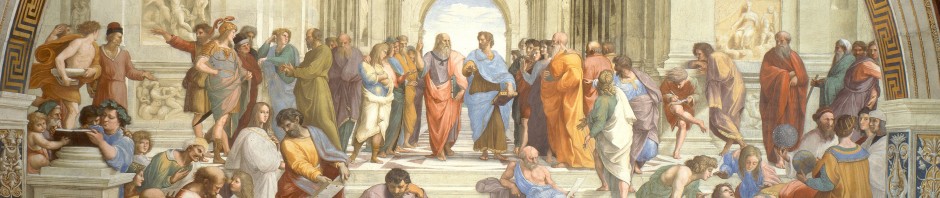Democrito fu allievo di Leucippo, fondatore dell’indirizzo atomistico, le cui idee di base furono esposte in un’opera intitolata “Grande cosmologia”. Democrito nacque intorno al 460 ad Abdera, la stessa città dove esercitò la sua attività Protagora, ed elaborò le tesi del maestro.
Anche l’atomismo si presenta come una dottrina pluralista, come quella di Anassagora, e si pone come obbiettivo quello di spiegare la molteplicità pur senza trasgredire l’insegnamento parmenideo. Democrito come Anassagora è convinto che tutta la realtà sia costituita da un’infinità di principi invisibili ad occhi nudo che lui chiama atomi, ma a differenza de semi anassagorei, non sono divisibili all’infinito (atomo = alpha privativo + temno “tagliare”), poiché se la realtà fosse divisibile all’infinito il mondo avrebbe cessato di esistere già da tempo. I semi di Anassagora inoltre differivano fra loro qualitativamente, mentre gli atomi sono tutti qualitativamente uguali. Aristotele, per spiegare in cosa differivano fra loro gli atomi democritei, si serve come esempio delle lettere dell’alfabeto, quindi gli atomi differiscono per forma come la A si distingue dalla N, per ordine nell’aggregato come AN è diverso da NA e per posizione come N è diverso da Z, inoltre Aristotele chiama le lettere dell’alfabeto stoicheia (elementi) così come gli atomi sono gli elementi ultimi di cui è composta la realtà. Inoltre, proprio come l’essere eleatico, gli atomi sono ingenerati e indistruttibili.
Ma gli atomi non sono il solo principio costitutivo della realtà secondo Democrito, infatti egli afferma l’esistenza di un altro principio: il vuoto. Il vuoto è la condizione da cui non si può prescindere se si vuole parlare di moto atomico. Così, utilizzando una terminologia eleatica, Democrito chiama gli atomi e il vuoto rispettivamente essere e non essere.
Democrito attribuisce agli atomi un movimento di tipo pulviscolare, per capire cosa intendesse basta guardare la polvere in controluce, secondo lui infatti vi era un grande vuoto pieno di atomi che si muovevano ognuno in una direzione, scontrandosi, come le biglie su un tavolo da biliardo, si scatenano delle reazioni: gli atomi si respingono e cambiano direzione se non sono compatibili, mentre si uniscono l’uno all’altro se hanno forme compatibili l’una con l’altra. Da notare che dentro gli atomi non c’è mai il vuoto, pertanto gli atomi possono unirsi in aggregazioni ma mai in mescolanze. Un criterio fondamentale di aggregazione è dato dal fatto che il simile si unisce al simile.
L’atomismo è una dottrina materialista, determinista (dato un fatto A ne accade uno B) e meccanicista.
Anche l’anima per Democrito era composta di atomi e precisamente da atomi sferici. Democrito aveva notato come caratteristica fondamentale della vita era il calore e quindi, poiché il calore è prodotto dal movimento, era plausibile che gli atomi dell’anima fossero atomi che la cui forma garantisse un’elevata mobilità. La respirazione diventa un metodo per ricaricare gli atomi dell’anima, poiché il loro stesso movimento li porta a distaccarsi e a perdersi nell’ambiente circostante, cessando pertanto questa reintegrazione ha luogo la morte, sia del corpo sia dell’anima, che si disperde nell’ambiente, lasciando il corpo freddo. La teoria atomistica inoltre permetteva di spiegare alcuni fenomeni biologici come la riproduzione e la somiglianza fra figli e genitori.
La conoscenza avviene allo stesso modo che per Anassagora, infatti dai vari aggregati partono degli effluvi di atomi, che gli atomisti chiamano eidola, ossia immagini, che arrivano ai nostri organi di senso attraverso i pori presenti sulla nostra superficie corporea e rendono così possibile la percezione della realtà esterna, inoltre dal tipo di atomi dipende ovviamente il tipo di percezione, così atomi spigolosi ad esempio daranno luogo alla percezione di acido.
Lo stesso principio che sta alla base delle aggregazioni degli atomi, sta alla base della formazione delle città, ovvero il principio dell’aggregazione del simile col simile.
Anche Democrito afferma che la differenza fra gli uomini e gli altri animali sta nel possesso delle tecniche, che gli uomini avevano appreso e migliorato dalle tecniche degli animali: dal ragno ad esempio il tessere la tela, dalle rondini il costruire case.
Democrito ravvisa il principale obbiettivo da perseguire in vita nella euthymìa, ossia la tranquillità d’animo, il non lasciarsi turbare eccessivamente dalle passioni sia sul piano privato, sia su quello pubblico. Il modello di vita proposto da Democrito quindi è più quello dello studioso che mira a perseguire i suoi studi senza porsi problemi di altra natura.