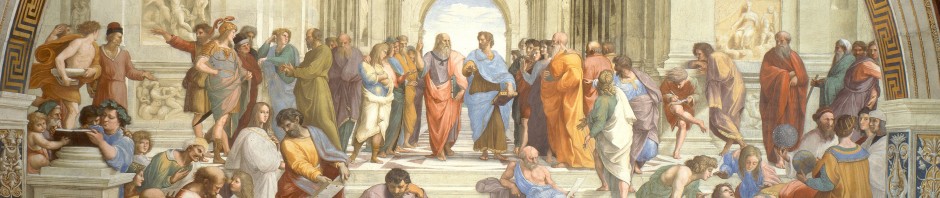Adesso che il cristianesimo godeva dell’appoggio imperiale, il neoplatonismo doveva in tutti i modi cercare di accentuare la sfera religiosa della sua dottrina.
Giamblico, nato a Calcide, in Siria, verso la metà del III secolo, dedicò una serie di scritti all’esposizione del pitagorismo e ai rapporti intercorrenti tra dottrine matematiche e speculazione teologica. Inoltre egli compose vari commenti agli scritti di Aristotele e ai dialoghi di Platone. La tradizione era per Giamblico un patrimonio immodificabile che va conservato fedelmente.
In Giamblico la differenza tradizionale fra i filosofi e il resto degli esseri umani, oltre che sul piano intellettuale si manifesta anche al livello dei culti praticati, i filosofi infatti praticheranno la teurgia, mentre per tutti gli altri ci saranno i culti della religione tradizionale. L’accettazione delle pratiche teurgiche comunque non significa che gli dei possono essere condizionati dagli uomini, infatti l’esito di queste pratiche dipende dal dio e non dall’uomo.
A differenza di Plotino, Giamblico postula l’esistenza di un principio supremo superiore anche all’Uno, egli lo chiama l’Ineffabile, ritenendo che questo sia l’unico vero nome per slegarlo da tutto il resto, infatti chiamandolo Uno lo si mantiene ancora in relazione, seppur soltanto negativamente, con la molteplicità. Tra questo principio è le ipostasi successive vi è continuità, così da procedere dal più semplice al sempre più complesso. Con Giamblico assistiamo ad una moltiplicazione delle ipostasi, cosicché possono trovare spazio fra le ipostasi anche la divinità del mondo pagano.