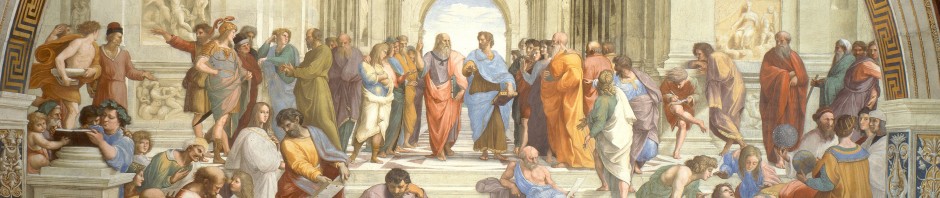Le fonti
La figura del sapiente stoico
La tripartizione della filosofia
La filosofia della conoscenza
Una teoria del linguaggio
La fisica stoica, la divinità, il logos
L’etica e l’anima
Le fonti
Verso il 300, Zenone di Cizio fondò in Atene un’altra scuola filosofica, la Stoà, la cui sede era nei pressi dell’agorà e questo è già di per sé sufficiente ad evidenziare le differenti vedute rispetto alla scuola epicurea. Degli scritti di Zenone a noi non ne è arrivato integro nessuno, così siamo costretti a ricostruire le caratteristiche di questa filosofia dalle riprese che ne faranno in età imperiale Seneca, Epitteto e Marco Aurelio. Nella direzione della scuola a Zenone successe Cleante di Asso, al quale poi successe Crisippo di Soli il quale intraprese un’opera di ricostruzione dello stoicismo e ne fu una sorta di secondo fondatore. Le opere di Crisippo erano piene di citazioni fatte da libri altrui, così che egli venne sovente indicato come parassita di libri. A Crisippo successe Diogene di Babilonia.
La figura del sapiante stoico
Riprendendo quanto già detto da Platone e Socrate, gli stoici tornano a far coincidere virtù e sapere, l’uomo virtuoso vero e proprio è il sapiente. Il sapiente infatti grazie alla sua sapienza si è sottratto all’area delle opinioni. Il sapiente stoico diventa così il vero erede della morale militare, ossia di colui che non si sposta mai dalla propria posizione resistendo a qualsiasi attacco, tanto delle passioni quanto della sorte. In questa prospettiva il dislivello rispetto alla divinità è praticamente azzerato. Tuttavia gli stessi stoici presentano la figura del sapiente stoico come una figura mai realmente esistita, o comunque esistita pochissima volte, quello che gli stoici volevano fornire era quindi un modello che proprio per la sua irraggiungibilità offrisse un modo di vivere completamente nuovo.
La tripartizione della filosofia
Gli stoici hanno una concezione unitaria della filosofia, cosicché le tre parti in cui è divisa non vanno assolutamente considerate slegate fra di loro: queste tre parti sono logica, fisica ed etica. La logica è come il guscio dell’uovo, l’etica è l’albume e la fisica è il tuorlo. Infatti se rispetto al vivere bene logica e fisica sembrano subordinate all’etica, sono comunque necessarie a raggiungere la sapienza che consente di vivere bene. La tripartizione della filosofia ha quindi per gli stoici soltanto una valenza espositiva.
La filosofia della conoscenza
Anche per gli stoici, come per gli epicurei, la conoscenza parte dalle sensazioni. Alla nascita infatti la nostra mente è una tabula rasa, una tavoletta di cera liscia, così non appena un oggetto esterno la colpisce si forma la rappresentazione (phantasìa), da diverse rappresentazioni della stessa cosa si formano i concetti, i quali possono essere collegati fra di loro per formarne altri, come ad esempio il centauro (mai si sperimenta il centauro, ma si sperimentano uomini e cavalli, pertanto siamo nelle condizioni di unire questi due concetti a nostro piacimento). A questa prima fase puramente passiva della conoscenza, fase che Zenone paragona alla mano aperta, ne segue una dove invece il nostro intelletto ha un ruolo attivo, questo deve infatti dare l’assenso o non darlo alla rappresentazione, questa fase viene paragonata alla mano mezza chiusa ed è sulla sospensione di questo assenso che si baserà la filosofia scettica. La mano stretta a pugno è invece la katalepsis, ovvero la comprensione, nel senso letterale di afferrare. L’errore secondo gli stoici può nascere nel momento in cui si da l’assenso, per malattie o distorsioni varie, a qualcosa che non è reale. Il criterio di verità pertanto non può essere dato da qualsiasi rappresentazione ma soltanto dalla rappresentazione catalettica o comprensiva, definita da Crisippo come quella che “proviene da ciò che è, è impressa in esatto accordo con ciò che è e non può provenire da ciò che non è”, a questo tipo di rappresentazione non si può non dare il proprio assenso. La conoscenza vera e propria, o scienza, paragonata all’afferrare una mano con l’altra, si ha nel momento in cui si afferra così bene una cosa al punto che la nostra comprensione di essa non può essere minata da alcuna argomentazione.
Una teoria del linguaggio
Gli stoici si dedicarono allo studio della grammatica indicando i termini per indicare i tempi dei verbi o i casi dei nomi, termini che rimasero utilizzati. Per quanto riguarda la sfera del linguaggio gli stoici individuano tre elementi: l’oggetto reale, per esempio un cane in carne ed ossa, il significante, ossia l’insieme di suoni che da luogo alla parola cane, e il significato (lektòn) ossia ciò che voglio dire esprimendo quella parola e che mi consente di collegare il cane in carne ed ossa al suono “cane”. L’oggetto reale e il significante sono corporei, mentre il significato è incorporeo. La logica stoica si divide nella retorica, ovvero la scienza dei discorsi lunghi, e nella dialettica, che ha come oggetti i significati.
I significati possono essere incompleti, come nel caso di verbi senza soggetto, oppure completi ed solo per questi ultimi casi che si può distinguere tra vero e falso, ossia se corrisponde o meno allo stato di cose manifestato dalla rappresentazione catalettica. Secondo gli stoici in natura non esistono gli universali, ma soltanto i particolari, pertanto frasi come “l’uomo è un animale razionale”, non si possono definire propriamente vere o false, bisogna invece dire “se qualcosa è un uomo, allora è un animale razionale. Particolare interesse viene da loro rivolto alle proposizioni collegate mediante le particelle “e”, “o” e “se”: una proposizione composta in cui le due semplici sono legate dalla congiunzione “e” secondo loro è vera soltanto nel caso in cui entrambe le proposizioni sono vere, se invece sono legate da “o” la proposizione è vera soltanto nel caso in cui solo una delle due proposizioni è vera (disgiunzione esclusiva), per quanto riguarda invece le proposizioni condizionali essi concordano con Filone nell’affermare che sono false soltanto nel caso in cui la premessa è vera e la conseguenza è falsa. Le proposizioni condizionali sono fondamentali per dare vita a delle argomentazioni. Le proposizioni condizionali si distinguono in concludenti, ovvero che funzionano, e non concludenti, ovvero fatti male e quindi non funzionanti. Quelle concludenti a loro volta si distinguono in veri e non veri e quelli veri in dimostrativi e non dimostrativi, ad esempio se io dico “se è giorno c’è luce, ma è giorno dunque c’è luce”, sto facendo un discorso concludente e veritiero, ma non dimostrativo infatti il fatto che c’è luce lo vedo prima ancora di fare il ragionamento, un ragionamento quindi per essere dimostrativo deve giungere ad una conclusione non manifesta. La dimostrazione è infatti per gli stoici quel ragionamento che partendo da premesse convenute giunge per via deduttiva ad una conclusione non evidente.
La fisica stoica, la divinità, il logos
Secondo gli stoici il mondo manifesta al suo interno due principi, uno attivo e uno passivo, quello passivo è per gli stoici la materia, mentre quello attivo agisce su di essa come causa efficiente per conferirgli la forma, ma la distinzione fra questi due principi è soltanto concettuale, nella realtà essi non possono essere disgiunti. Entrambi i principi sono corporei, infatti gli stoici riprendono la definizione di essere avanzata da Platone nel Sofista secondo cui “essere è tutto ciò che la possibilità di agire o subire un’azione”, quindi ciò che è incorporeo non può fungere da causa efficiente.
Gli stoici identificano questo principio attivo con la natura, o con Dio, che essi chiamano anche logos, ragione, esso quindi si mescola alla materia, per questo motivo la filosofia stoica viene vista come una forma di panteismo, ovvero una filosofia in cui Dio è presente in ogni singolo oggetto della realtà. L’esistenza degli dei secondo gli stoici è confermata, come già per Epicuro, dal consensus omnium, ma Crisippo formulerà anche un ragionamento, in perfetto accordo con la logica stoica, per giustificarne la presenza. Egli afferma: se al mondo esiste qualcosa che l’uomo non è in grado di produrre, allora questo qualcosa dev’essere stato prodotto da qualcosa di superiore all’uomo, ma al mondo esistono i mari e le montagne, quindi questo qualcosa esiste ed è Dio. Un’altra prova per affermare l’esistenza degli dei, era di tipo finalistico e asseriva che la divinità organizza tutto nel migliore dei modi possibili, infatti tutto è organizzato in vista dell’uomo che può servirsi di tutte le altre specie animali, il male stesso appare in questa visione come un sottoprodotto del bene, ad esempio le ossa della testa sono fragili, ma questa fragilità è dovuta alla loro particolare conformazione che gli consente di adempiere meglio ai loro compiti.
I primi stoici, come Zenone e Cleante, identificarono questo logos con il fuoco, come aveva già fatto Eraclito. Secondo loro il mondo nasce e perisce in continuazione, così alla fine di ogni ciclo tutto si sarebbe dissolto nel fuoco e dal fuoco tutto sarebbe poi rinato. Questo grazie al fatto che nel logos cosmico sono presenti i vari logoi spermartikoi, ovvero i singoli logos delle entità esistenti, e tutto sarebbe rinato uguale, d’altronde se fosse stato diverso si sarebbe dovuto ammettere che questo nuovo mondo o quello precedente non sarebbe il migliore dei mondi possibili, ma questo è in contrasto con la visione finalistica del tutto propria della concezione stoica. Ma già da Crisippo questo logos venne identificato con lo pneuma, ovvero un soffio di aria e fuoco che con la sua azione avrebbe tenuto insieme gli altri due elementi. Essendo quindi l’universo un grande organismo attraversato da questo soffio caldo, è giusto dire che tutto l’esistente è collegato, da qui il concetto stoico di simpatia, ovvero ogni evento caratterizza tutti gli altri eventi, infatti gli stoici sono generalmente propensi ad accettare l’astrologia.
Si può facilmente intuire a questo punto come per gli stoici acquisisse notevole importanza il concetto di causa, ogni evento infatti è strettamente legato a tutti gli altri. Il caso per gli stoici non è altro che un modo per definire quelle cose di cui non conosciamo la causa. Crisippo distingue tra due tipi di cause, le cause esterne e le cause interne, ad esempio se prendo una pallina e le do una spinta, la pallina si mette a rotolare, in questo caso la causa esterna sono io che do la spinta, ma la causa interna è la forma della pallina che le consente di reagire in un determinato modo alla causa esterna che quindi è notevolmente meno importante di quella intera, la stesa causa esterna infatti applicata ad un cubo non avrebbe sortito lo stesso effetto.
L’etica e l’anima
Le pneuma è presente nella realtà in diversi gradi: negli oggetti inanimati si limita a tenerli insieme, nelle piante è presente sottoforma di natura nel senso stretto della parola, ossia dà loro le funzioni vitali, negli animali e negli uomini è presente sotto forma di anima. L’anima umana per gli stoici è anch’essa corporea. Loro rifiutano la tripartizione dell’anima fatta da Aristotele, infatti per essi l’anima è un principio unitario dove il comando è di proprietà della ragione, le stesse appetizioni e passioni dipendono da un atto intellettivo, ad esempio quando si vede un dolce gli si da l’assenso e gli si da quindi un valore, di conseguenza lo si ritiene meritevole di essere mangiato e si è spinti a farlo. Allo stesso modo le passioni dipendono da un giudizio falso su ciò che è bene e male, ad esempio l’avidità giudica il denaro un bene.
Ogni essere vivente è in principio portato ad amare se stesso e risponde solo al principio di autoconservazione, quindi tenderà a soddisfare la sete, la fame e così via, soltanto crescendo si sviluppa la ragione che fa sì che ci si renda conto che la cosa propria dell’uomo è la virtù. Anche la virtù per gli stoici è corporea, essa infatti non è altro che l’anima in condizioni eccellenti e per raggiungere questa condizione sarà necessario comportarsi secondo la propria natura, così gli esseri razionali per raggiungere la virtù dovranno comportarsi secondo ragione e quindi compiere le azioni non in base ad un impulso, ma in base ad un ragionamento tale da consentire in seguito una loro giustificazione. La virtù per gli stoici è l’unica cosa che ha valore assoluto, tutte le altre cose infatti hanno un valore soltanto relativo, la ricchezza quindi è preferibile alla povertà, ma non è un ingrediente della virtù, tant’è che furono stoici sia un imperatore come Marco Aurelio sia uno schiavo come Epitteto. Gli stoici ravvisano il fine dell’uomo nella felicità, ma dimenticano di fare, come invece aveva fatto Aristotele, la distinzione tra felicità e felicità compiuta, infatti secondo loro all’uomo non serve nulla per essere felice oltre la virtù. La virtù inoltre non ammette gradi, cioè non si può essere un po’ virtuosi, ma o si è virtuosi o non lo si è, così come non c’è differenza fra l’essere un metro sotto l’acqua o dieci metri sotto l’acqua, in entrambi i casi non si è fuori dall’acqua. Il passaggio alla virtù quindi, là dove avviene, è istantaneo e totale.
Com’è possibile vivere secondo virtù? L’ambiente in cui un uomo vive e il risultato delle sue azioni non dipendono certo dall’uomo, è importante quindi l’intenzione con cui un uomo agisce e il suo modo di reagire di fronte alla realtà che lo circonda. È a proposito del vivere virtuosamente che gli stoici introducono il problema della libertà umana. Seneca dirà “ducunt volentem fata, nolentem trahunt”, ossia “il fato conduce chi si vuole far condurre e trascina tutti gli altri”. Gli stoici fanno il paragone del cane legato ad un carro, il cane necessariamente correrà, può solo decidere se correre di sua spontanea volontà oppure farsi trascinare. La libertà quindi consiste nell’accettare o meno il destino, per questo motivo solo il sapiente può essere libero, egli infatti è l’unico che conosce alla perfezione l’ordine razionale dell’universo. Proprio per questo motivo la schiavitù giuridica non ha più alcuna importanza, poiché anche uno schiavo può diventare sapiente e lasciarsi condurre dal fato. A questo punto vediamo come per gli stoici, il sapiente ha orizzonti più ampi di quelli della città, il sapiente è come se vivesse all’interno dell’intero cosmo, i sapienti è come se fossero una comunità a parte, un po’ come aveva già detto Ippia ponendo le basi per un atteggiamento cosmopolita.
Gli stoici a differenza degli Epicurei, incitavano alla vita politica, anche se comunque la maggior parte degli esponenti dello stoicismo non ne prese mai attivamente parte.